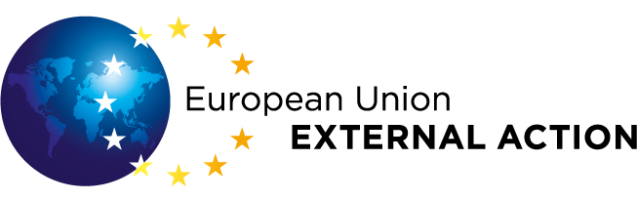Fornire beni pubblici e tutelare i beni comuni globali: uno sforzo arduo
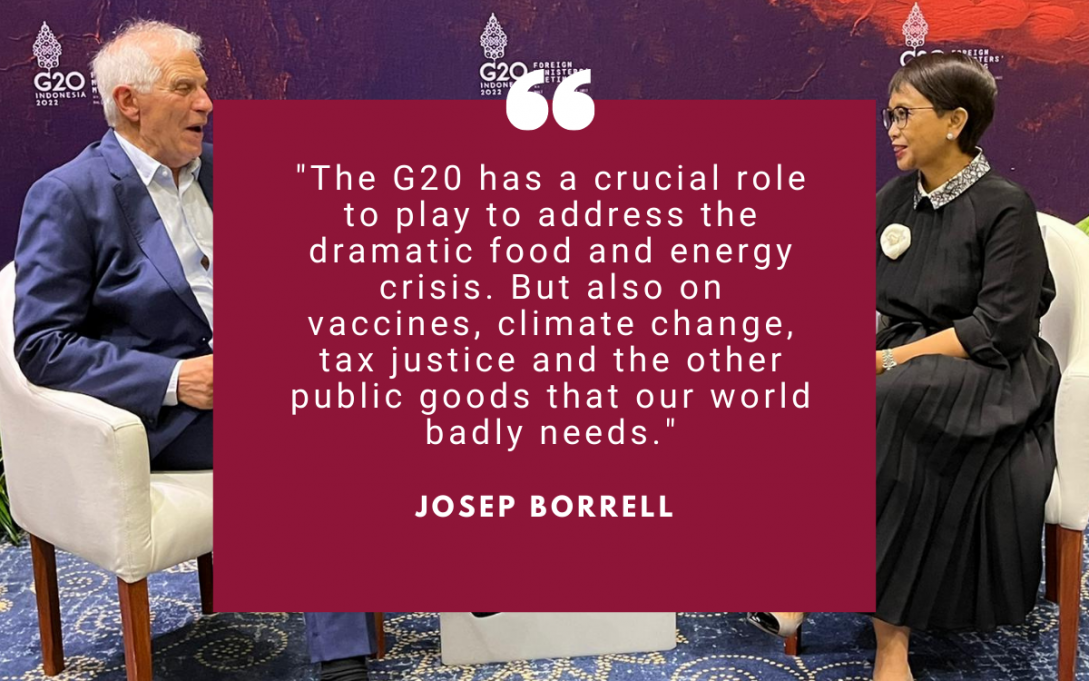
"Il G20 ha un ruolo fondamentale da svolgere per far fronte alla drammatica crisi alimentare ed energetica, ma anche per quanto riguarda i vaccini, i cambiamenti climatici, la giustizia fiscale e gli altri beni pubblici di cui il nostro mondo ha disperatamente bisogno."
Un classico problema della politica internazionale è come produrre beni pubblici e avere cura dei beni comuni globali. È facile affermare che vogliamo preservare la pace e la sicurezza, vaccinare il mondo intero, affrontare la crisi climatica, proteggere la biodiversità o combattere l'evasione fiscale, come pure spiegare perché lo vogliamo. Ma in assenza di un governo mondiale, realizzare tutto ciò è difficile, in quanto richiede immensi sforzi di cooperazione e solidarietà. E questo è ancora più vero oggi, alla luce dell'inasprirsi delle divisioni geopolitiche dovuto all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.
Quando si tratta di problemi globali, ciascun paese beneficia chiaramente dell'azione collettiva, ma la tendenza è quella di aspettare che qualcun altro prenda l'iniziativa e ne paghi il prezzo (è il cosiddetto "dilemma del free rider"). I leader politici affermano spesso, in discorsi altisonanti, che la comunità internazionale deve agire in un modo o nell'altro. Eppure le loro azioni dimostrano che le considerazioni nazionali spesso prevalgono sulle esigenze internazionali. È un peccato, ma non ne siamo sorpresi: i politici nazionali sono responsabili davanti agli elettori nazionali e il nazionalismo continua a essere una forza politica notevole.
Per decenni studiosi e diplomatici hanno discusso di come affrontare questo dilemma e la soluzione migliore che hanno trovato è il cosiddetto "multilateralismo basato su regole". L'espressione è forse poco piacevole, ma si riferisce essenzialmente all'intero sistema di norme, organizzazioni e modalità di finanziamento — tra Stati e attori non statali — ideate per affrontare le sfide globali e fornire beni pubblici globali. Le Nazioni Unite e il Consiglio di sicurezza rappresentano il perno di questo sistema, attorno a cui girano molte organizzazioni e agenzie operative, quali l'OMC, l'OMS, l'FMI, la FAO, l'UNFCCC ecc.
Tra il 1945 e l'inizio del XXI secolo abbiamo assistito a una crescita significativa nel sistema multilaterale, che ha prodotto molti risultati: da una maggiore aspettativa di vita e una riduzione della povertà a livello mondiale a crescenti standard di vita e una maggiore alfabetizzazione, ma anche all'eliminazione di malattie come il vaiolo o di sostanze chimiche dannose come i clorofluorocarburi (CFC), a cui è imputato il buco nell'ozono, che ora si sta richiudendo.
Naturalmente nello stesso periodo sono venuti alla luce e si sono vissuti molti altri problemi, altre crisi, tra cui quella del debito e quella finanziaria, o ancora l'incapacità di regolamentare il "lato oscuro" della globalizzazione. Eppure, in termini storici, "il sistema" ha prodotto risultati: la fame si sta riducendo e sempre più persone, soprattutto donne, beneficiano di una migliore istruzione e di una vita più longeva, più sana e più libera.
Sfortunatamente da alcuni decenni il sistema deve fare i conti sempre più con la tendenza generale verso il populismo a livello nazionale e la competizione geopolitica tra i principali attori. Osserviamo più sfiducia, nazionalismo e free riding di quanto il mondo possa permettersi. Come ho osservato nel mio recente discorso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, vi è una "carenza di multilateralismo" e il prezzo da pagare sono i problemi non risolti e le persone lasciate alla mercé degli eventi.
Alcuni esempi concreti illustrano sia le dinamiche che osserviamo sia la necessità che l'UE continui a investire in un multilateralismo efficace, soprattutto quando le tendenze politiche rendono difficile farlo.
1. Vaccini. Tre settimane fa la rivista The Lancet ha pubblicato un importante studio secondo le cui stime i vaccini contro la COVID-19 hanno evitato circa 15 milioni di morti nel primo anno della loro diffusione. Si tratta di una cifra sconcertante. A metà giugno, secondo Our World in Data, il 67% della popolazione mondiale aveva ricevuto almeno una dose. La percentuale scende però al 18,6% per i paesi a basso reddito e il numero di morti evitate è fortemente concentrato nei paesi sviluppati che sono stati in grado di vaccinare la propria popolazione. La dura verità è che il COVAX, il principale veicolo multilaterale sostenuto fin da subito dall'UE e istituito per gestire in modo equo la campagna vaccinale mondiale, non è stato in grado di realizzare i suoi obiettivi nel 2021 (soprattutto a causa delle restrizioni alle esportazioni).
Nell'esportazione e nella donazione di vaccini, come anche nel sostegno al multilateralismo vaccinale, l'UE ha ottenuto risultati migliori di Cina, Russia, India o Stati Uniti. Ma dobbiamo fare ancora di più con i nostri partner per "vaccinare il mondo intero", come avevamo promesso di fare, anche sostenendo maggiormente la capacità di produzione in Africa, fornendo supporto logistico e combattendo l'esitazione vaccinale, che continua a rappresentare una sfida persistente. Dobbiamo inoltre rafforzare l'OMS per garantire che in futuro il mondo sia, nel complesso, più preparato a gestire eventuali emergenze di sanità pubblica.
2. Cambiamenti climatici. Su carta l'accordo di Parigi è stata una vera pietra miliare: un accordo globale, giuridicamente vincolante, per combattere i cambiamenti climatici. La sua attuazione ha rappresentato però una vera sfida e la più recente relazione di valutazione dell'IPCC è deprimente: 3,5 miliardi di persone sono già altamente vulnerabili agli impatti climatici e metà della popolazione mondiale soffre a causa di gravi penurie d'acqua.
Essenzialmente le emissioni di carbonio aumentano più velocemente di quanto il clima possa permettersi. Dopo la riduzione di CO2 dovuta alla pandemia nel 2020, le emissioni sono nuovamente aumentate del 6% nel 2021 e sono al momento superiori ai livelli del 2019. Se l'ambizione globale non aumenterà in modo significativo, il mondo sforerà gli obiettivi dell'accordo di Parigi, con tutto quanto ne consegue, anche in termini di sicurezza globale.
Dobbiamo fare di più in quanto UE, ed è quello che stiamo facendo con il nostro pacchetto "Pronti per il 55%", appena adottato. Ma dobbiamo convincere altri attori in grado di fare di più a unirsi a noi e aiutare a preparare i paesi più fragili e maggiormente esposti al clima ad affrontare le inevitabili e crescenti ripercussioni della crisi climatica. La COP 27 che si terrà quest'anno al Cairo sarà un momento cruciale, anche per la mobilitazione di 100 miliardi di USD in finanziamenti per il clima. Non possiamo permettere che l'urgenza della crisi energetica che fronteggiamo attualmente sovrasti la minaccia permanente rappresentata dai cambiamenti climatici.
3. Biodiversità. Le minacce alla biodiversità sono spesso meno note di quelle al clima, ma le conseguenze sono almeno altrettanto dannose per il pianeta e la nostra sussistenza. Secondo le stime delle Nazioni Unite, su un totale di 8 milioni di specie vegetali e animali esistenti, un milione è a rischio di estinzione. Secondo la Banca mondiale, da oltre dieci anni la superficie ricoperta da riserve forestali (come l'Amazzonia) diminuisce di 5 milioni di ettari l'anno. Negli ultimi cento anni le barriere coralline si sono dimezzate, il 35% degli stock marini è oggetto di pesca eccessiva, ecc.
La diagnosi è chiara: quello di cui abbiamo bisogno è, di nuovo, un'azione internazionale più determinata. Gli impegni previsti dai precedenti piani d'azione delle Nazioni Unite nel settore non sono stati attuati in modo sufficiente. La 15ª riunione delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD) si terrà in dicembre in Canada e dovrà adottare decisioni fondamentali in merito a proposte volte a proteggere il 30% della terra e del mare, alla riduzione del deflusso chimico agricolo e al ripristino di almeno un quinto degli ecosistemi di acqua dolce, marini e terrestri degradati.
4. Giustizia fiscale. Ogni anno l'elusione fiscale priva i governi di tutto il mondo, già a corto di liquidità, di entrate pari a 100-200 miliardi di USD. La scorsa estate, dopo lunghi negoziati, è stato raggiunto un accordo storico nel quadro del G20: oltre 135 paesi e giurisdizioni hanno concordato un approccio OCSE "a due pilastri per riformare le norme in materia di fiscalità internazionale e garantire che le imprese multinazionali paghino una giusta quota di tasse ovunque esse operino". Si è trattato di un considerevole risultato acclamato da più parti, me incluso. È sia un passo avanti nell'affrontare il problema dell'evasione fiscale per costruire una forma più equa di globalizzazione, che un esempio quanto mai necessario dei risultati significativi realizzabili grazie alla cooperazione multilaterale.
È quindi molto frustrante che l'UE, a causa dell'opposizione di uno Stato membro, non sia ancora riuscita a recepire tale accordo internazionale nel diritto dell'UE. Ci stiamo dando la zappa sui piedi: i nostri cittadini vogliono vedere dei progressi in materia e tutti i governi necessitano di entrate per affrontare le varie crisi con cui dobbiamo misurarci. È anche difficile spiegare ai nostri partner che un'Unione che fa vanto delle proprie credenziali multilaterali non è in grado di rispettare l'impegno assunto. Ciò non farà altro che incoraggiare quanti già nutrono riserve a bloccare la loro ratifica. È il contrario di quello di cui il mondo ha bisogno: invece di dare impulso al multilateralismo, siamo in una situazione di stallo.
Investimenti nell'azione multilaterale
Ogni caso è diverso, ma quello che tutte queste questioni hanno in comune è che per ciascun bene pubblico globale è stato individuato il problema ed è stato istituito un quadro internazionale per risolverlo. Il sistema fatica però a produrre risultati della portata e alla velocità necessarie.
Nei casi in cui il problema dipende dall'UE, non abbiamo davvero scuse e possiamo solo tener fede ai nostri impegni. Per definizione, tuttavia, l'UE non può risolvere questi problemi da sola: le organizzazioni regionali possono contribuire, ma non possono fornire beni pubblici globali. Per farlo è necessario che ciascuno si impegni maggiormente, soprattutto i paesi sviluppati.
Il contesto geopolitico dato dalla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina sta ovviamente complicando le cose. Si osserva un inasprimento delle tensioni che si diffondono in tutti i consessi multilaterali. È ovvio che dobbiamo difendere i nostri principi e i concetti fondamentali dell'ordine basato su regole contro oppositori revisionisti quali la Russia e la Cina. Allo stesso tempo dobbiamo continuare in qualche modo a collaborare con tutte le potenze per trovare una soluzione alle questioni globali. Per trovare tale equilibrio sono necessari un continuo adeguamento e uno stretto coordinamento con i partner che condividono gli stessi principi. La riunione dei ministri degli Esteri del G20 in Indonesia rappresenta un momento cruciale in tal senso, soprattutto per quanto riguarda la drammatica crisi alimentare ed energetica, ma anche per i vaccini, il clima e gli altri beni pubblici di cui il nostro mondo ha disperatamente bisogno.
MORE FROM THE BLOG

"Una finestra sul mondo"- Blog dell'AR/VP Josep Borrell
Blog di Josep Borrell sulle sue attività e la politica estera europea. Contiene anche interviste, op-eds, una selezione di discorsi e video.